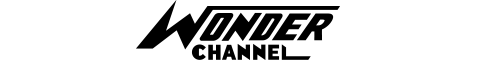Approdato come un film molto apprezzato da grandi critici, nelle sale le opinioni dello spettatore medio è stato molto contrastante. In questo articolo valuteremo alcuni elementi salienti del film.
Il cast di Killers of the Flower Moon è colmo di stelle del cinema d’oltre oceano. L’epopea del sogno americano infranto -come raccontato da grandi scrittori dell’epoca quali Francis Scott Fitzgerald- si esprime con prepotenza inaudita delle immagini.
Il film, come una grande poesia, fila in una narrazione non sempre incalzante, ma logica e lineare nella sua semplicità.
La società Statunitense sta vivendo un periodo di forte controversie intestine: gli Indiani devono vivere al fianco dei bianchi, la guerra civile porta con se ancora qualche strascico, e per le strade implode l’odio profondo dei superstiti di guerra, pronti, di li a poco, a far sentire il proprio malessere. Ed è proprio con questi pretesti che parte il film: un superstite di guerra interpretato da Leonardo DiCaprio, un eccentrico benestante interpretato da Robert De Niro che cova un rancore nei confronti dei pellerossa e l’impressione costante di un’America spaccata dai rancori interiori e dai sogni infranti della luccicante promessa dell’epopea a stelle e strisce. È il sogno che diventa incubo.
Leonardo DiCaprio è incredibilmente credibile e coinvolgente, ma le sue enormi capacità non vengono sfruttate pienamente. Leonardo, nel tempo, ci ha conquistato con l’interpretazione di personaggi ossessionati ed acuti. Questo Ernest Burkhart non è nessuna delle due. È il classico cittadino medio che ha combattuto in Europa per servire il proprio paese, ma senza tornare in patria con le problematiche del combattente di Tom Doss (“La Battaglia di Hawksaw Ridge”) e nemmeno con la sindrome post traumatica da non combattente di Dick Diver (“Tender is the night” di Francis Scott Fitzgerald). Leonardo è un attore adatto a facoltose personalità istrioniche quale quella di Gatsby o di Jordan Belfort, o di controverse e strabilianti anime tormentate quale quella di Rick Dalton (li il regista era Quentin Tarantino).
Tuttavia è un Leonardo che ha acquisito una certa maturità e che, dopo l’apice della sua carriera toccato con Revenant-Redivivo, comincia a studiare sempre più le espressioni di divi assoluti del cinema. In alcune inquadrature sembra aver acquisito una dominanza assurda, senza tempo, frutto, probabilmente, di uno studio approfondito delle interpretazioni del Marlon Brando anni settanta.
Da Marlon Brando passiamo al Padrino, da Godfather al Vito, da Vito a Robert De Niro. Robert anima un tracotante William Hale, un massone al trentaduesimo livello che, senza fronzoli, affronta con crudele austerità e mirabile acume la società in cui vive. Si presenta come un promotore di pace e prosperità, tuttavia la sua figura resta ammantata in un velo di caligine fino al finale, dove si dimostra realmente la glaciale incarnazione della concupiscenza e della slealtà. Robert non ha bisogno di aggettivi, l’attributo maggiore che ha ricevuto è probabilmente il riconoscimento eterno dal mondo del cinema. Sebbene ciò, mi duole sottolineare un curioso aneddoto: durante le riprese Robert De Niro sembra non aver gradito le insistenti richieste di Leonardo DiCaprio; quest’ultimo pare aver dominato le riprese con frequenti domande al regista circa il senso delle scene, nonché sul significato della storia, ed inoltre sembra aver imperato a Scorsese di far ripetere qualche ciack per risultare maggiormente credibile ed apprezzabile agli occhi del pubblico. Se confermato tutto ciò potrebbe solo indicare che l’appetito di Leonardo DiCaprio non pare soddisfatto; al contrario, Robert De Niro si dimostrerebbe o maggiormente sicuro, o semplicemente satollo della perfezione plastica e della ricerca spasmodica della migliore versione di se.
La regina della scena, però, va a Lily Gladstone. Lily inscena un’indiana civilizzata di nome Mollie, la quale è ormai perfettamente inserita nella società bianca. Accetta i costumi altrui, ma continua a vestire i propri e a difendere il suo nucleo familiare da misteriosi omicidi che minacciano la stabilità del potere e della ricchezza avita. C’è un problema, Mollie è molto cagionevole di salute ed è costretta a convivere con il diabete. Nel corso del film (senza anticipazioni, ovviamente) Lily si dimostra un asso nell’incarnare l’ardore della malattia, la sindrome da avvelenamento e la depressione in seguito alle numerose delusioni che la tormentano. È una donna inizialmente illusa di poter vivere per sempre nel suo locus amoenus; con il tempo si rende conto che il sogno che stava vivendo non era altro che un affranto affresco del desiderio di inclusività tipica delle democrazie nascenti. E così si deprime, ma non si rassegna e continua a lottare per la propria vita e quella della propria tribù. Non aspettatevi una Boudicca contemporanea, nemmeno una Mohicana, bensì una donna morigerata e distrutta dalla viltà e dalla nequizia del seme mostruoso della cupidigia e della vanità. È una donna voluttuosa, passionale, sensibile ai suoi drammi, temprata ed attiva nel mondo della politica indiana.
Ogni personaggio raffigura un simbolo (ma quasi certamente anche più di uno).
Ernest è la banalità di Arendt: un uomo che commette atroci crimini e che si macchia di sangue senza obiettare agli ordini impartiti dallo zio William.
William è la Serpe della Genesi: serpeggia e tenta gli uomini con denaro e promesse di ricchezza e poi li stronca relegandoli alla morte, ovvero all’eterna e disincantata realtà del mondo. Un satana insigne dalle vesti di uomo, dall’amena eleganza, dall’inclito fascino e dalla delicata gentilezza. È il tentatore per eccellenza, il Lucifero che viene attorniato dalle fiamme (come peraltro accade in una scena del film) e che trascina con se i dannati (Divina Commedia e Paradise Lost).
Mollie è l’emblema dell’amore vero, terreno: vive per la sottile semplicità. Non ha pretese, ambizioni, vuole solo godersi i figli, amare la vita ed i suoi piaceri, legarsi alla natura ed alla sua famiglia. Ama il marito come lui ama lei. Eppure quest’equilibrio risulta essere oltre che precario anche fatale. E la sublime sfida è quella di resistere alla intemperie dell’esistenza non tanto con la disinvoltura inanimata, ma con sensibile coscienza dell’universo che l’accerchia. Mollie è come una stella: non brilla di luce propria, ma solamente di quella riflessa. Probabilmente la sua devastata anima, costantemente travolta da atroci malvagità compiute a sua insaputa da persone molto vicine a lei, è il vero specchio del film. È l’amore ciò che Scorsese ci condivide: un amore per la ricchezza, uno per la famiglia, uno per le origini, uno controverso e setacciato in un coacervo di sapori sprigionati da un mortaio che pesta forte su un otre di pietra. Mollie è la vera protagonista del film? Probabilmente no.
La Recensione
Killers of the Flower Moon
Ciò che davvero trionfa è il messaggio finale: armonia nel caos, caos nell’armonia. È una sorta di entropia della società, una regola che contraddistingue le vicende storico-sociali dell’integrazione. È come se Scorsese avesse tentato di legiferare cinematograficamente una norma assoluta che racchiude i precetti intelligibili della sapienza, del logos umano. È questo davvero ciò che ci aspettavamo da Martin? No. Assolutamente. E con ciò non nego che alla fine del film, specialmente per la durata e la presenza di alcune scene superflue, si rischia una bella e forte emicrania.
PRO
- Storia vera
- Attori strabilianti
- Racconto perfetto della società dell'epoca
- Fotografia
CONTRO
- Durata
- Personaggi secondari non sufficientemente approfonditi
- Poco dinamico in alcuni punti
- Finale abbozzato