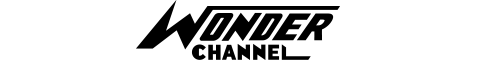Venerdì 15 settembre ho passato una serata differente dalle solite e ho deciso di condividere con voi tutto quello che è successo e le sensazioni che mi ha lasciato.
Vi racconto le mie cronache del Cantiere Poetico.
Il Cantiere Poetico è un evento che si tiene a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, e che dura circa una settimana che, arrivato alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di riconoscere il lavoro dei poeti del “circolo del giudizio“. Santarcangelo, infatti, è patria di tantissimi poeti dialettali come Tonino Guerra, Antonio Baldini, Gianni Fucci e moltissimi altri.
Quest’anno, però, il Cantiere Poetico è stato dedicato ad uno dei più importanti poeti dialettali della zona: Nino Pedretti.
Chi era Nino Pedretti
Nino Pedretti era, oltre che importantissimo poeta dialettale, era un insegnante di lingua inglese nei licei di Cesena e Pesaro. Nonostante fosse un letterato, c’è in lui l’esigenza di pubblicare opere in dialetto romagnolo e ciò non lo penalizzò. Anzi, la sua prima raccolta di poesie in dialetto romagnolo, Al vòuşi, pubblicata nel 1975, riscuote un enorme successo.
Ecco cosa diceva Pedretti riguardo il dialetto.
«A differenza dell’italiano, arrotolato nei codici, levigato ed illustre, il fratello umile, il dialetto, è vissuto all’aperto come un’erba selvatica, bagnato dalla pioggia dei secoli e come un’erba pertinace di gramigna, si è arrampicato sui monti, si è addentrato nei minimi villaggi, ha coperto ogni metro di terra dove viveva la gente comune del lavoro e dei sacrifici.»
Cronache del Cantiere Poetico
Venerdì 15 settembre ho deciso di partecipare ad una serata in cui, oltre Nino Pedretti, protagonista incontrastato di tutta la rassegna poetica, un grande artista è salito sul palco a parlare del poeta e di come l’ha influenzato nella sua scrittura: Mannarino.
La serata è stata molto particolare, in quanto, l’atmosfera e il rapporto creato con il pubblico era quasi come quello di una casa piena di amici. E lì il cantautore romano si è raccontato, descrivendo in che modo Pedretti abbia influenzato il suo modo di scrivere.
È stato interessante il modo in cui il sindaco di Santarcangelo, Alice Parma, sia venuta a conoscenza del fatto che Mannarino leggesse le poesie di Nino Pedretti: la sindaca ha raccontato di aver casualmente visto un post su Facebook in cui Mannarino leggeva una poesia di Pedretti e, allora, lì non si è potuto fare a meno di invitarlo alla rassegna di quest’anno.
L’intervista a Mannarino
Quando togli un cantiere vedi un bel palazzo. Quando il Cantiere Poetico finirà non vedremo nulla. Il risultato è invisibile e lo vedremo nell’uomo che guarda la donna in modo diverso.
La serata si è svolta più come una chiacchierata tra amici che come un’intervista vera e propria, ma è riuscita a coinvolgere tutto il pubblico presente all’interno del Teatro Supercinema di Santarcangelo.
Ecco cosa dice del Cantiere Poetico: “Il nome Cantiere Poetico è bello perché ti dà l’idea di qualcosa che si costruisce in un paese che è pieno di cantieri. Quando togli un cantiere vedi un bel palazzo. Quando il Cantiere Poetico finirà non vedremo nulla. Il risultato è invisibile e lo vedremo nell’uomo che guarda la donna in modo diverso.
Le case si possono demolire, i libri bruciare, ma le poesie, una volta imparate a memoria, non te le toglie nessuno. La poesia ti mostra la sua libertà di usare le parole e funziona più di un modello politico.
Vivere la poesia nella vita ti rende un essere umano più libero e coerente, la poesia ti mette a disposizione dei nuovi occhiali con cui guardare il mondo.”
Poi il cantautore ci racconta di come ha conosciuto la poesia di Nino Pedretti: “Mi trovavo in Salento e dei miei amici mi hanno detto «Devi venire a Nardò, ti dobbiamo fare conoscere un libraio che conosce le tue canzoni!» Così siamo andati a Nardò e c’era questa piccola libreria scavata nel tufo. Il libraio era molto umile e l’umiltà è la caratteristica delle persone molto intelligenti. Il libraio mi dice «Penso che tu debba leggere Pedretti» e io gli ho detto «E chi è?» e lui mi ha risposto «È un poeta dialettale romagnolo». Mi ha venduto tre suoi libri e quel giorno stesso li ho letti tutti.
Della sua scrittura mi ha colpito il modo in cui parla di noi esseri umani e del mondo affrontando la caducità dell’esistenza umana senza bramosia, descrivendo le piccole cose.“
Subito dopo, ecco che ci si perde tra le parole delle poesie di Pedretti: “A E’ Temp che Caschevva al Baracocli” (Al Tempo che Cadevano le Albicocche), “U N’E’ Savrà Niséun” (Non lo Saprà Nessuno) e “La Chèrta Zala” (La Carta Gialla) sono state le tre poesie prescelte per la lettura sul palco e per essere tradotte direttamente da Mannarino in romanesco. “La leggo io? La faccio in romanesco (ridendo)? No, no. Ma la rovino! Mi fate fare davvero questa cosa? Però, vabbè, da dialetto a dialetto. Ho il permesso dei figli quindi… Io improvviso.”
Il valore del dialetto
La bisnonna si affacciava dalla finestra e gridava parole con cadenza romagnola che lì non aveva nessuno. Noi non sapevamo che era un dialetto, pensavamo che era una sua particolarità.
Subito dopo, Anna Pedretti, figlia di Nino, gli chiede: “Che senso ha per te scrivere in dialetto? Come ti vengono le canzoni? Prima in dialetto o in italiano? Come ti suona il dialetto romagnolo, che sensazioni ti dà?”
“Riguardo al dialetto, a me è venuto naturale perché è la prima lingua che ho imparato, prima dell’italiano. L’italiano è la lingua della burocrazia, è la lingua ufficiale, calata dall’alto. E calata dall’alto, in effetti, perché l’Italia è stata messa in piedi dall’alto.
L’Italia è stata unita con una lingua che è imposta, invece i dialetti sono nati, sono cresciuti nei territori, si sono arrampicati come un’erba selvatica, come dice Nino Pedretti, sono la lingua della classe subalterna. Il dialetto è proprio questo, perché dà la voce ai subalterni. Io avevo fatto la tesi di laurea su questo, Antropologia, e ovviamente avevo nascosto i capitoli peggiori, li ho infilati alla fine. Sono andato all’università, immaginate la discussione, io che dico «la mia tesi è che la scuola è un’istituzione che perpetua la distinzione fra le classi.» e la commissione mi dice «Ma si rende conto di quello che è venuto a dire qui?» Stavo nel mio periodo rivoluzionario, mi hanno tolto dei punti alla laurea però ero contento di fare questo.
Spesso si fanno pure gli inganni con l’italiano perché chi ti vuole fregare parla l’italiano perfetto, sia che sia un venditore di contratti di assicurazione sia il politico. È questo quello che fa la lingua ufficiale. Il dialetto è una lingua ufficiosa, una lingua che non ha niente di ufficiale perché non ci sono contratti che tengano, quando stai odi una persona, quando stai litigando, parli in dialetto, quando la ami parli in dialetto, è qualcosa più legato al momento, alle viscere, alla ninna nanna della mia bisnonna. Quindi lo uso in modo naturale. E poi con il dialetto sono riuscito a dire cose per cui in italiano avrei dovuto imbastire tutta la cosa. Nel dialetto con tre parole, perché è molto più antico, sei abituato ad andare al punto, hai detto tutto.
Del dialetto romagnolo, avevo la mia bisnonna che era romagnola. Tutta la famiglia poi si è trasferita in una borgata romana, San Basile. La bisnonna si affacciava dalla finestra e gridava parole con cadenza romagnola che lì non aveva nessuno. Noi non sapevamo che era un dialetto, pensavamo che era una sua particolarità.”
Scrittura come necessità?
Volevo fare questo, volevo scrivere, sia che c’avessi campato che no.
Il palco viene, poi lasciato a Mannarino e al giornalista di Repubblica Pierfrancesco Pacoda.
“Per te lo scrivere è una necessità? O, si scrive solo per necessità?”
“Io quando avevo 8 anni avevo imparato appena a scrivere e la mia maestra in questa scuola della periferia romana mi fece il primo complimento, forse il primo complimento della mia vita. Ci ho creduto così tanto che ero bravo a scrivere che non mi sono più fermato. Mi aveva detto che avevo scritto una bella poesia. Poi allora ho pensato che ero bravo a scrivere poesie, che sapevo fare quello, ci ho creduto e, il mio passatempo a scuola era scrivere poesie che mia madre ancora ha perché le maestre le collezionavano e gliele davano. Poi avevo questa fiamma dentro che bruciava, che mi teneva sveglio la notte, perché mi ricordo a 15-16 anni andavo in cucina di nascosto di notte con una lucetta a scrivere poesie perché mi vergognavo a farlo davanti agli altri. Poi mi hanno regalato una chitarra e ho messo due note lì e ho visto che le parole che scrivevo avevano forse più emotività, più forza, perché erano mischiate con la musica. Mentre su un concetto tu scrivi, se ti racconto una storia triste piangi e tu sai perché, perché ti ho raccontato una storia. Con la musica tu ascolti e piangi e non sai perché. Va a toccare i nervi. Volevo fare questo, volevo scrivere, sia che c’avessi campato che no.
[…] Io ho trovato nello scrivere un’ancora di salvezza, un rifugio da un mondo che non mi piaceva, una famiglia che mi diceva cazzate da quando ero nato. Per me scrivere e leggere sono qualcosa che hanno sciolto dei nodi dentro, mi hanno aiutato a fidarmi del calore, a non diventare freddo, di ghiaccio. Poi è difficile avere il coraggio di andare avanti quando il mondo va da tutt’altra parte, perché vali se sei uno sveglio, se hai le attività, il macchinone.”
“Nello scrivere canzoni, tu ti fai mai il problema della responsabilità?”
“Ho la responsabilità di scrivere una bella canzone (risata del pubblico). Non è sempre facile. So che ho ancora molta ricerca da fare. Quando ti incontri con i mostri sacri, quando senti dei dischi, più li ascolti e più ti rendi conto delle banalità delle cose che fai. Io di ricerca finora ne ho fatta poca. C’è da imparare. Quando volevo uscire con il disco tutti mi dicevano «tu sei pazzo, togli i pezzi in dialetto, ma chi te sente» ma io ero sicuro. Questo è un atteggiamento di ricerca: seguire la mia visione, cerco di non essere accondiscendente.”
“Però a lungo andare ti premia. C’è un sentire comune secondo te?”
“Siamo ostaggio delle case discografiche. Stanno lì ad appiattire tutti per suonare tutte le cose uguali. Poi c’è sto stress che devi andare in radio. Ma io ormai la radio non la sento. È un posto che non mi piace. Invece la casa discografica dovrebbe puntare. Vuoi fare il business? Punti. Come si faceva una volta. Invece cercano di avere quei due /tre panini che vendono e che devono essere tutti uguali.
La mia lotta è quella di riuscire a essere mainstream nel senso che voglio avere l’opportunità di arrivare a tutti, perché io nella nicchia non ci ho mai creduto. Se io devo andare a parlare con la gente che la pensa come me è tempo sprecato, devo andare dove c’è uno scontro, dove c’è una dialettica.
Lo stesso discorso della poesia. Alle donne si vende la narrativa femminile. Poi a uno viene anche il dubbio che sia un progetto, per cui una massa tutta uguale è più facile da gestire. Se hai una popolazione che legge poesia hai paura, perché è gente viva.”
Il live acustico e l’aneddoto su “Il Bar della Rabbia”
Questo è quello che fa la poesia: costruisce astronavi con la spazzatura.
Alla fine dell’intervista, sul palco ritroviamo un Mannarino che prende in mano la sua chitarra e chiede al pubblico cosa vorrebbe ascoltare.
Inizia con “Marylou” e poi conclude con “Il Bar della Rabbia“, di cui racconta la nascita.
“Abitavo in una casa dove eravamo in 10, di cui 2 nascosti. Che c’erano però non c’erano. Andavano a fare la doccia nascosti, cucinavano in camera col fornetto perché erano, che ne so, il ragazzo di una oppure l’amico, e quindi nascosti perché sennò dovevano dividere le spese.
E io facevo il dj, tornavo tardi, e quella sera era quasi l’alba. Tornavo con la mia macchina e avevo in testa sto “er giro a vuoto de l’anello cascato ar dito de la sposa” cominciavo a dire versi “so un fantasma, parlo e me vie l’asma” quasi hip hop.
Però mi sono fermato a un bar «Dateme una penna e un foglio per favore, devo appuntare ste cose che c’ho paura de dimenticarmele». Sono tornato a casa, ho dormito fino al pomeriggio successivo, mi sono svegliato, ho preso la chitarra e ho cominciato a provare la canzone e dicevo «ammazza che schifo». Stavo al primo piano e sotto c’era un bar, e con questo scorcio condominiale, dopo un’ora che provavo, mi è venuta tutta la canzone.
E quando alla fine dico «Quattro ragazzini hanno fatto n’astronave co n po’ de spazzatura vicino ai secchioni, sotto le mura dove dietro nun se vede e c’è n’aria scura scura. Ma guarda te co quanta cura se fanno la fantasia de st’avventura» questa è l’arte. È la poesia. Fare un’astronave con la spazzatura. «Dietro le mura dove dietro nun se vede» sono le mura dove arriveremo tutti prima o poi e dopo de la è buio e non sappiamo niente. Però ci facciamo sta fantasia. E questo è quello che fa la poesia: costruisce astronavi con la spazzatura.”
L’esperienza è stata molto intima ed è riuscita a toccare l’anima anche di gente come me che non è abituata a leggere poesie.
Oggi il Cantiere Poetico è alla sua ultima giornata ma avrà come ospite un altro grande artista: Nada, che presenterà il suo nuovo libro.